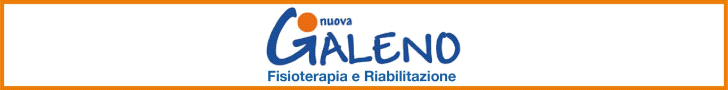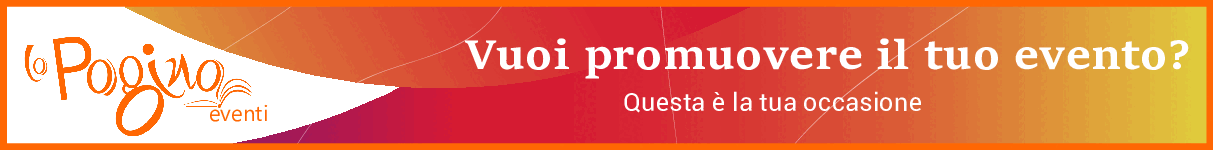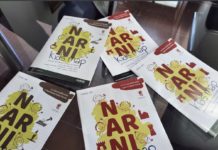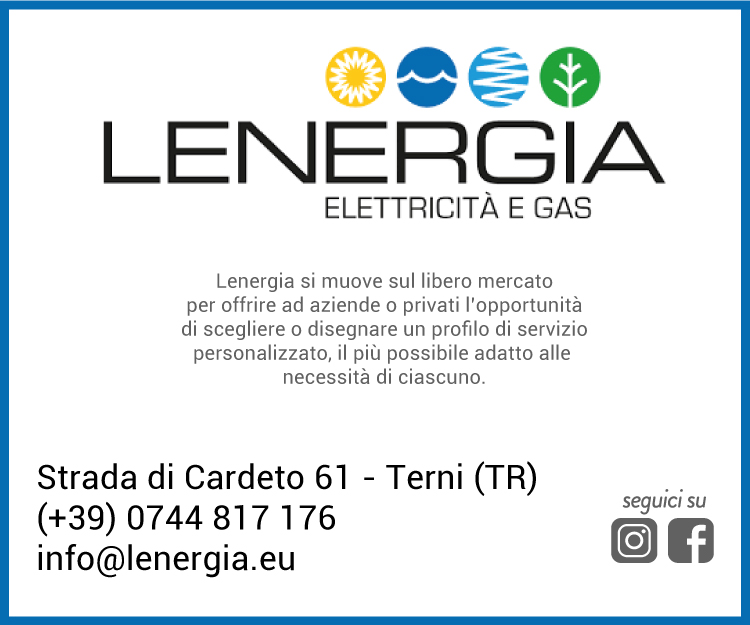Speriamo che sia femmina: un augurio che cambia nel tempo
A quanto pare, augurare di avere figli maschi non è più tanto di moda. Sondaggi e statistiche mostrano che, un po’ ovunque, cresce la speranza che nasca una femmina.
Per molti aspetti è una buona notizia. Ma indica anche qualcosa di meno buono, un segno dei tempi nuovi: il timore crescente che i maschi facciano cose sbagliate, se non orrende, e la speranza radicata che le femmine si prendano cura dei genitori anziani.
Tradizioni popolari e previsioni sul sesso del nascituro
Quando non era stata ancora inventata l’ecografia, c’era sempre almeno una donna in ogni quartiere o in ogni frazione sperduta tra i campi, che, guardando e toccando la pancia di una gravida, pronunciava la sua previsione.
Tutti dicevano che era bravissima a prevedere il sesso del nascituro sbagliando di rado.
Queste convinzioni nascevano perché le volte che ci azzeccava rimanevano impresse nella mente di tutti, mentre quando sbagliava, predominava una più facile dimenticanza.
Speranze diverse tra figli e animali da stalla
In quei tempi il sesso del nascituro era molto importante sia nella famiglia che nella stalla.
Nella famiglia contadina che aveva bisogno di braccia per lavorare i campi, si sperava nella nascita di più maschi e meno femmine.
Nella stalla invece si sperava il contrario.
Speriamo che sia femmina… anche tra gli animali
Quando una vacca, una cavalla o un’asina andavano in calore, quindi erano feconde, venivano portate a essere maritate a pagamento col maschio corrispondente nelle stazioni di monta dove c’era il toro, lo stallone o l’asino.
Si diceva che il toro bello facesse il vitello bello, ma questa frase veniva usata anche quando nasceva un neonato somigliante più ad un uomo della zona che al marito della puerpera.
Dalla vitella all’asinella: una questione di valore
Se fosse nato un vitello, dopo i giusti mesi dell’allattamento, sarebbe stato venduto al macellaio come carne, guadagnandoci poco.
La vitella invece poteva essere allevata, domata al giogo, per esempio a sinistra, e venduta a un altro contadino come adatta a trainare un carro o un aratro.
Così anche l’asinella, il cui valore superava quello dell’asinello.
Speriamo che sia femmina anche nel pollaio
Con i polli analogo ragionamento: bastava un gallo per ogni pollaio insieme a tante galline.
I maschi venivano castrati per diventare capponi per il pranzo di Natale, le femmine restavano per la produzione di uova e per sostituire la gallina vecchia, “che fa buon brodo”.
Il maiale e l’importanza del grasso
Per i maiali era diverso: maschi e femmine venivano castrati e venduti alle famiglie per essere ingrassati.
Fino al 1960 circa, un maiale doveva avere almeno uno spessore di 15 cm di grasso: il grasso alimentare veniva quasi tutto dal maiale.
Il proverbio ternano e il significato nascosto
C’era anche un proverbio in dialetto:
“La fémmina nun ze sposa se nun cià lu pennènte, lu rizzènte e lu pisciannante.”
Oggi quasi nessuno lo comprende più. La traduzione spiega che la donna non si sposava se nella casa non c’erano:
- il pezzo di lardo appeso (lu pennènte)
- il sacco della farina pieno (lu rizzènte)
- la botte del vino colma (lu pisciannante)
Speriamo che sia femmina: uno sguardo sul futuro demografico
Come conclusione possiamo dire e sperare che, se nascono più femmine che maschietti, quelle a loro volta faranno dei figli che potrebbero farci uscire tra alcuni anni dall’inverno demografico nel quale ci troviamo adesso, col numero degli ultraottantenni che hanno superato quello dei bambini con meno di dieci anni.
Vittorio Grechi