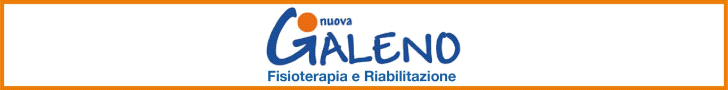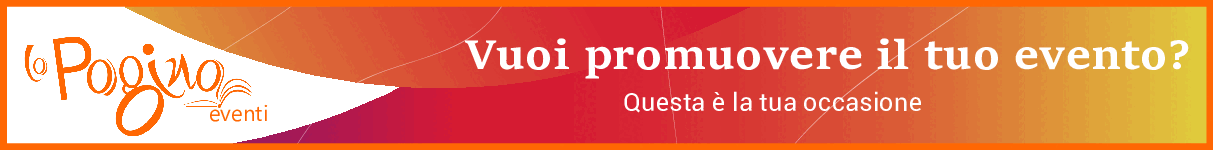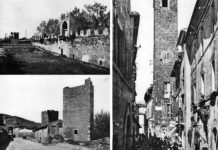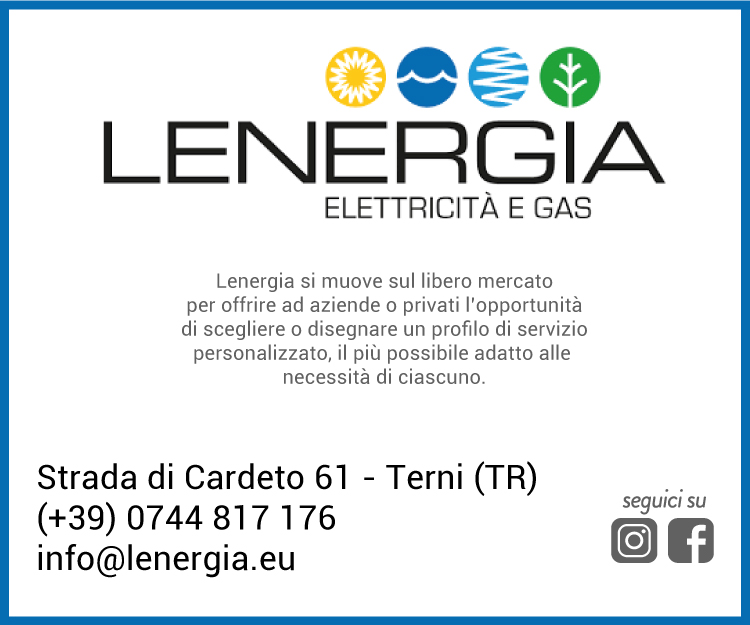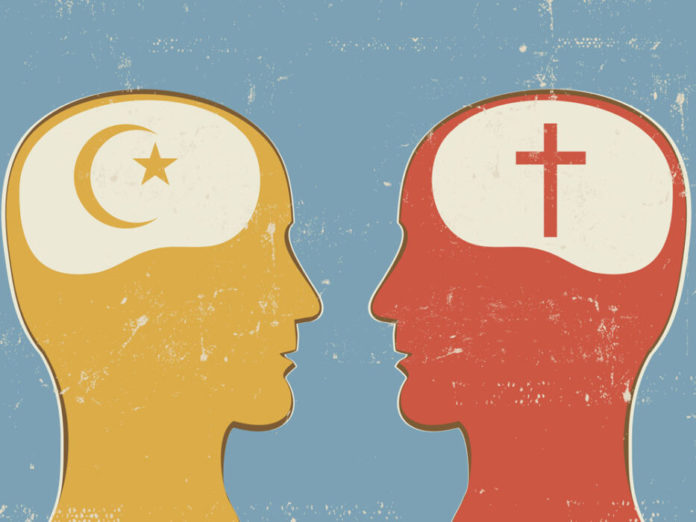
Dal bipolarismo del Novecento a nuove tensioni globali
Nella seconda metà del Novecento il panorama geopolitico mondiale era dominato dalla contrapposizione tra due blocchi: da un lato il blocco occidentale, guidato dagli Stati Uniti, e dall’altro il blocco sovietico, dominato dall’Unione Sovietica. Il simbolo più evidente di questa divisione era il Muro di Berlino, che separava rigidamente la città tedesca in due parti, riflettendo la frammentazione della Germania e del mondo.
La fine della Guerra Fredda e l’emergere dell’Islam radicale
Con la caduta del Muro nel 1989 il sistema bipolare cominciò a sgretolarsi, fino alla dissoluzione dell’URSS. Gli Stati Uniti rimasero l’unica superpotenza egemone. Tuttavia, dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 emerse un nuovo bipolarismo: l’Occidente si trovò a fronteggiare un fondamentalismo islamista organizzato, che andava a colmare il vuoto lasciato dalla Guerra Fredda.
Scontro di civiltà? Le tesi di Huntington e le nuove fratture
Questo nuovo scenario sembrava confermare la tesi del politologo Samuel Huntington, secondo cui i conflitti futuri sarebbero derivati da differenze culturali, non più ideologiche o economiche. A differenza della contrapposizione tra due blocchi unitari, lo scontro tra Occidente e Islam si rivelò frammentato, con contraddizioni interne su entrambi i fronti.
Islam politico tra fede, società e legge divina
L’Islam è una concezione globale della vita e della società, più che una semplice religione. Può essere vissuto come rapporto individuale con il trascendente oppure come principio ispiratore dell’organizzazione sociale. In quest’ultimo caso, il proselitismo si trasforma in militanza, e la fede diventa motore di azione politica, anche con l’uso della forza, per instaurare un ordine conforme alla legge divina.
Il Corano tra spiritualità e ordinamenti civili
Anche nei Paesi a maggioranza musulmana che tentano vie laiche, come la Tunisia, il Corano resta un riferimento fondamentale. È in questo contesto che il dialogo interreligioso si rivela essenziale: presuppone comprensione, superamento dei pregiudizi, rispetto della libertà di coscienza e delle culture altrui.
Etnocentrismo e laicità: i fraintendimenti dell’Occidente
L’etnocentrismo è la tendenza a giudicare tutto con le proprie categorie culturali. Credere di non avere pregiudizi è il pregiudizio più comune. La laicità, spesso mal interpretata, non è cancellazione delle tradizioni ma imparzialità. Il presepe, ad esempio, è anche un simbolo di speranza condiviso, poiché Gesù e Maria sono rispettati anche nell’Islam.
Immigrazione e integrazione: la realtà demografica in Europa
La crescita demografica delle popolazioni musulmane in Europa è spesso evocata con preoccupazione. Ma studi demografici mostrano che, con il tempo, il tasso di natalità degli immigrati tende a convergere con quello delle popolazioni ospitanti, anche grazie a istruzione, modelli familiari occidentali e matrimoni misti.
Convivenza multiculturale: diritti, leggi e rispetto reciproco
La convivenza richiede rispetto reciproco e il riconoscimento della pari dignità. Il rispetto delle leggi del Paese ospitante è imprescindibile. Parlare solo di tolleranza può risultare riduttivo: ciò che serve è piena integrazione basata sull’uguaglianza, non condiscendenza.
Democrazia e Islam: due modelli a confronto
L’Islam è una cultura forte che richiede adesione piena ai principi coranici, mentre le democrazie occidentali si fondano su pluralismo e sovranità popolare. In certi casi, il rispetto delle norme religiose può entrare in conflitto con le leggi civili. Senza accettare la supremazia delle leggi statali, la costruzione di una società realmente multiculturale resta estremamente difficile.
Roberto Rapaccini
Hai perso gli articoli precedenti di Roberto Rapaccini?
Visita il nostro archivio per leggere tutti i contenuti già pubblicati.