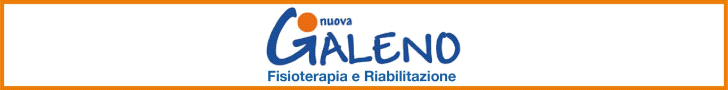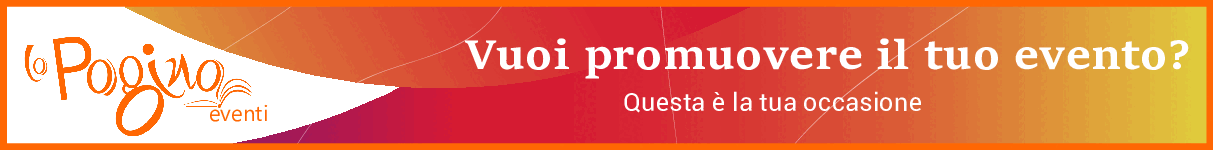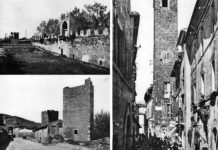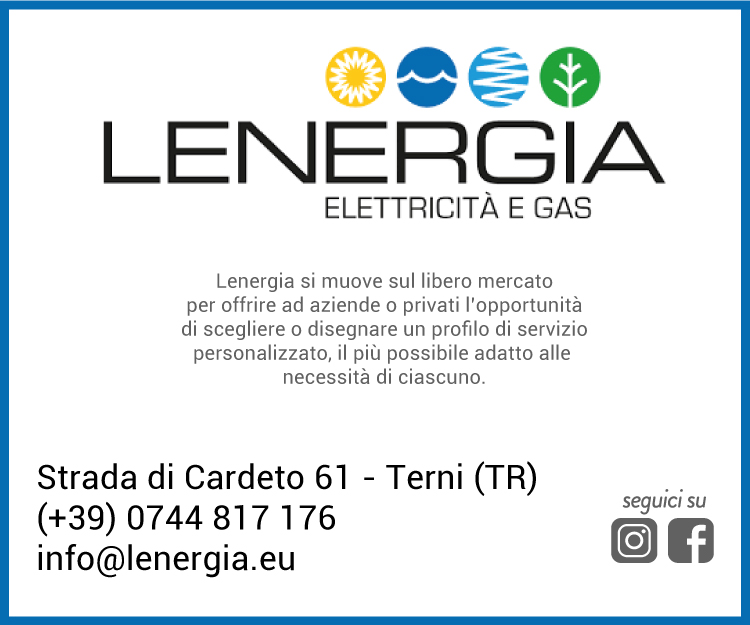Papa Francesco
Un vuoto profondo per credenti e non credenti
Molti, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno parlato di un “vuoto” dopo la morte di Papa Francesco. Si tratta di un vuoto morale, umano e sociale. Il Pontefice era diventato un punto di riferimento universale, apprezzato anche dai non credenti.
Papa Francesco si era guadagnato questa autorevolezza grazie alla sua attenzione verso le persone fragili e sofferenti. Ha promosso la giustizia sociale e la solidarietà umana. Ha difeso la pace, minacciata da guerre nazionalistiche, dalla crisi del multilateralismo e dalla corsa al riarmo.
Laudato si’: il legame tra ecologia e fraternità
Il Papa ha anche dimostrato un impegno forte per l’ambiente. L’enciclica Laudato si’, incentrata sulla cura del pianeta, resta un testo chiave. Il documento lancia un messaggio chiaro: solo la fraternità può salvare l’umanità.
C’è una profonda consonanza tra Laudato si’ e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Entrambe sono state pubblicate nel 2015 e denunciano i cambiamenti climatici, la gestione irresponsabile delle risorse e l’aumento delle disuguaglianze. Anche gli Accordi di Parigi, siglati lo stesso anno, si ispirano a quella visione. Oggi, però, molte potenze mondiali li ignorano.
Un Papa inascoltato dal potere globale
Le posizioni di Papa Francesco su clima, guerre e migrazioni hanno evidenziato la distanza dai centri di potere. Ha parlato di una “terza guerra mondiale a pezzi” e ha criticato le politiche migratorie repressive.
Il mondo lo ha ascoltato, soprattutto nelle periferie e tra chi ha buona volontà. I governi e i poteri forti, invece, lo hanno spesso ignorato. Anche dentro la Chiesa, i rapporti con alcune conferenze episcopali, come quelle americana e tedesca, sono stati difficili.
Pacifista, ecologista, in minoranza nella sua Chiesa
Papa Francesco ha incarnato valori progressisti e profetici. Nonostante ciò, spesso ha dato l’impressione di essere in minoranza nella sua stessa comunità.
Ha portato avanti una linea riformatrice ispirata al Concilio, cercando una Chiesa più vicina agli ultimi e più aperta. Tuttavia, non tutti hanno accolto questa direzione con favore.
La sfida della successione: riforma o ritorno al passato?
La sua morte apre un interrogativo cruciale. Quale direzione prenderà la Chiesa? Ci sarà continuità con la linea riformatrice o un ritorno al tradizionalismo?
Il timore di molti è che la sua voce, forte e chiara a favore dei più deboli, venga spenta. La successione sarà decisiva per il futuro della Chiesa cattolica e per il suo ruolo nel mondo.
Giacomo Porrazzini
Hai perso gli articoli precedenti di Giacomo Porrazzini?
Visita il nostro archivio per leggere tutti i contenuti già pubblicati.